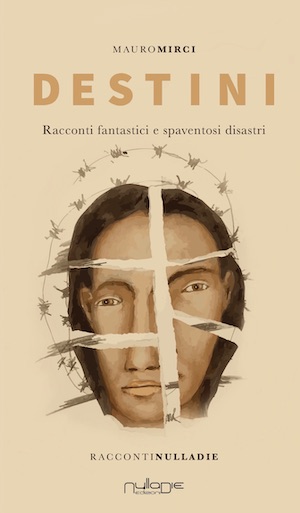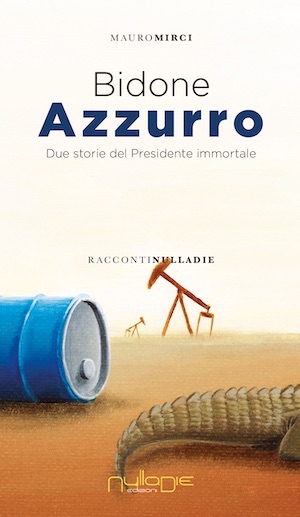di Mimmo Marchetta
Tuttora quella strada – la vecchia e angusta 115 – continuo a percorrerla, specie d’estate, sia per evitare il traffico convulso dello scorrimento veloce, ma soprattutto per un motivo sentimentale. La vecchia statale 115 che scende da Ribera verso il Magazzolo e il Platani e da lì, un tempo, costeggiata da maestosi e robusti pioppi, ora ridotti a pochi ruderi, mostrava, prima di giungere a Montallegro, sul lato sinistro un paesaggio singolare, costellato di collinette cretose e increspate come da rughe sulla pelle di un elefante. Questo fu lo scenario consueto e familiare che si offriva a me che da ragazzino feci spesso quella strada che ora costituisce una di quelle strade secondarie e quasi in disuso che mi viene di chiamare le strade della nostalgia. Per quella strada mi portavano spesso con il loro “camioncino” due fratelli che avevano una piccola industria per la lavorazione del pesce in scatola a Siculiana Marina. In qualche altra occasione prendevo anche il trenino, quello a vapore, tutto ferro e lamiera, sedili di legno duro, ancora senza un’ombra di plastica.
I fratelli del “camioncino” mi portavano da Ribera a Siculiana Marina dove i miei nonni materni si trasferivano in estate giacché mio nonno, pure lui, aveva l’industrietta di salati. Quando irrompeva la primavera cominciavano per me i tuffi al cuore al pensiero che sarebbe da lì a poco iniziata per me la bella avventura del mare, dei bagni, del vento fresco salino che spirava dal mare e quasi stordiva, specie se tenevi gli occhi chiusi. Sarebbero cominciati, sotto il sole cocente, assieme ai compagnetti del posto, gli appostamenti silenziosi sopra gli scogli alla ricerca di polpi, granchi, gamberetti che apparivano e sparivano in un baleno. Oppure le corse in costume da bagno verso quel tratto di mare antistante lo stabilimento della tonnara, dove i cuochi che avevano bollito e inscatolato il tonno, venivano a buttare quelle parti non adatte alla conservazione o sbriciolate ma molto gustose per noi ragazzini che ci tuffavamo sott’acqua per raccoglierle e mangiarle ingordamente. I tonni venivano arpionati e tirati su un barcone enorme nelle mattanze al largo della costa, dove, quando era il momento, i “tonnaroti” con in testa il loro capo (il “rais”) si recavano coi loro barconi tutti neri di pece, trainati dal vaporetto dei “Florio”.
I due fratelli che mi ospitavano sul loro agile mezzo di trasporto, spesso non avevano spazio sufficiente in cabina ed era naturale, allora, che prendessi posto sul cassone scoperto, in piedi e tenendomi ben saldo al passamano di ferro retrostante la cabina di guida e guardando la strada che durante la corsa mi veniva incontro insieme al vento fresco e pulito che scompigliava i capelli, mozzava a tratti il respiro e impediva di tenere bene aperti gli occhi. Il segnale evidente che ci avvicinavamo alla destinazione erano quelle due collinette accostate, che man mano ci si avvicinava e cambiava la prospettiva, si scostavano una dall’altra, mostrando l’oggetto del desiderio: un lembo dell’amato mare, luccicante per i raggi del sole che vi battevano in pieno e provocavano un bagliore accecante. Era quello l’attimo della gioia incontenibile e non paragonabile a nessuna altra cosa conosciuta.
Ad ogni estate, giungendo al mare, usavo sempre contare le barche dei pescatori tirate a secco sulla spiaggia. Non erano, ricordo, meno di quaranta, tutte messe in fila. Ed ero contento del fatto che fossero così numerose e che rispetto all’estate precedente non fossero diminuite di numero. Ma poi, quando andavo crescendo mi accorgevo che il loro numero si andava assottigliando sempre più. Fino ad alcuni anni addietro, ancora alcune se ne vedevano infossate nella sabbia, già fuori uso. Poi sono sparite anche queste. Una sola resisteva, fino all’ultimo, come un relitto. Credo proprio che fosse quella di “zio Lorenzo”.
“Zio Lorenzo”, tra i marinai della borgata, era il più esperto. Conosceva i segreti del mestiere e i mille risvolti del tempo, del vento, delle bonacce, dei bizzarri comportamenti del mare. Chi doveva avventurarsi al largo ed era dubbioso del tempo, andava da lui a chiedere cosa si prevedeva per quel giorno e per la notte. Ora non c’è più. Da qualche anno “zio Lorenzo” se ne è andato. Avrebbe da lì a poco compiuto novantaquattro anni. Conosceva bene il suo lavoro e l’esercitava con una certa sacralità. Mi sono accorto, una volta, dal modo impacciato di tenerle in mano, che non conosceva altrettanto bene le monete e il loro effettivo valore. Non si era, si vede, adeguato ai loro alti e bassi. Lui andava a pesca. Erano gli altri della famiglia ad occuparsi del lato economico. Aveva visto cambiare tante cose e credo non tenesse più sotto controllo il valore effettivo dei soldi. Negli ultimi anni, per una serie d’acciacchi, il suo mare e la sua barca se li guardava dal balcone che dava proprio sulla spiaggia. La barca ormai in disarmo e tristemente insabbiata in un angolo, lontano dalla battigia.
Quando i marinai tornavano dalla pesca, all’alba, dopo avere patteggiato e venduto all’asta il pesce agli abituali compratori, uno sciame di salatrici era già pronto nei magazzini per “salare” le sardine e le acciughe e con questo lavoro arrotondare i magri guadagni dei loro mariti. Le salatrici lavoravano allegramente a volte cantando; spesso raccontandosi a voce alta storie, fatterelli, pettegolezzi e così far trascorrere il tempo piacevolmente.
Gli equipaggi delle barche, dal canto loro, già sciacquavano le reti facendole scorrere dalla barca nell’acqua, ripulendole così dalle alghe e dalla scamorze rimaste impigliate nelle maglie delle reti. Poi le raccoglievano arrotolandole su una cerata disposta sulla battigia. Altri marinai dell’equipaggio se le caricavano sulle spalle, protette da un telo impermeabile, percorrevano in fila, come in cordata, la spiaggia, e man mano le facevano srotolare e distendere sulla sabbia per asciugarle al sole. Prima di mezzogiorno le reti erano asciutte e ora l’equipaggio di ogni barca si disponeva sotto un telo fissato sui remi conficcati nella sabbia (una capanna improvvisata) a ricucire gli strappi alle reti provocati dalle “fere”, con dei grossi “aghi” di legno che contenevano arrotolato il filo adatto a ricostruire le maglie danneggiate. Ultimato il lavoro, per quel giorno i marinai non rientravano in famiglia per il pranzo, anche se alcuni abitavano nella borgata, a pochi passi dalla spiaggia.
C’era un addetto alla cucina che preparava da mangiare per l’equipaggio, sotto la tenda, improvvisando un focolare con due grosse pietre, una accanto all’altra, la legna e i rami secchi (“satareddri”) raccolti in giro per la spiaggia e una grossa pentola. Si accendeva il fuoco con quei rametti secchi che in un attimo divampavano con un velocissimo crepitio. Il pranzo solitamente consisteva in una pietanza di sardine cotte in un gustoso e profumato brodino con cipolle, patate e pomodori, oppure le sarde infilzate negli spiedi di canne tagliate lisciate e appuntite lì per lì con un coltello. Dopo il pranzo, anche il riposo e la dormitina pomeridiana avvenivano sotto la tenda come a perpetuare un antico rito.
Qualche volta, trovandomi in spiaggia, dopo avere fatto il bagno, andavo curiosando qua e là e mi fermavo anche a guardare i marinai che consumavano il loro pranzo sotto la tenda. Ricordo anche che una volta, proprio “zio Lorenzo”, che mi conosceva, mi invitò a pranzare con loro sotto la tenda, offrendomi il piatto con le sardine in brodo.
Il magazzino dei salati di mio nonno era proprio di fronte al tratto di mare dove man mano alle prime luci dell’alba approdavano le barche che rientravano dalla pesca.
Di notte mio nonno, forse dormendo con un occhio solo quando era in attesa che arrivasse la prima barca carica di pesce, era sempre pronto a scendere in spiaggia, con la sua pipa accesa, cominciando a valutare la qualità della merce che man mano arrivava.
Qualche volta, mentre lui si preparava per scendere in spiaggia, mi svegliavo al rumore dei suoi passi mentre girava per casa. Poi l’osservavo da una finestrina mentre sulla battigia andava avanti e indietro nell’attesa delle barche, sotto uno sciame di stelle e una luna splendente che illuminava tutto il cielo e il mare e le colline intorno. Ed io lì in mezzo, a guardare dalla finestrina, smarrito e intimorito a spiare quell’universo illuminato che vedevo per la prima volta, e non sapendo chi io fossi e perché ero lì. Quelli erano per me i primi meravigliosi spettacoli pieni di mistero nei silenzi delle notti. Poi quando le barche cominciavano ad arrivare più numerose e appariva il primo chiarore dell’alba, la spiaggia si animava di sagome e voci più distinte, quelle dei compratori che cominciavano a popolare la spiaggia. Svaniva il silenzio, aumentava il vocìo, il chiarore si faceva sempre più vivo, le voci erano sempre più distinte e familiari e, assieme al chiarore e all’animazione della spiaggia, anch’io, dietro la finestrina, mi rincuoravo. Ora riconoscevo quel mondo e, rasserenato, mi aggrappavo al nuovo giorno.
Quando cominciarono a costruire il porto, “zio Lorenzo” non era molto convinto della giustezza del progetto. Avrebbe voluto che il braccio destro fosse orientato in modo diverso per essere, secondo lui, più funzionale e contrastare i venti e le correnti e rendere più agevole l’approdo delle imbarcazioni. Al direttore dei lavori lo gridava tante volte dal balcone, ma naturalmente non fu ascoltato.
Oggi quel braccio del porto è quasi tutto a secco, insabbiato, essendosi il mare ritirato di molto. Quando non c’era il porto, l’acqua del mare arrivava quasi a lambire alcune abitazioni. Le quaranta barche che contavo lungo la spiaggia in un tempo lontano, non ci sono più. Al loro posto tanti fuoribordo di plastica; le barche dei turisti dilettanti pescatori. E una lunga fila di auto parcheggiate al posto di quelle quaranta barche dei pescatori. Sono le auto dei vacanzieri alla ricerca di una pizzeria, una trattoria, per trascorrere la serata.
Con un certo disagio ora mi sento anch’io un turista sconosciuto in mezzo a tanti altri che non conosco. Solo ogni tanto capita d’incrociare lo sguardo fugace di un superstite dei tempi mitici. E mi viene in mente “zio Lorenzo” mentre tiene maldestramente tra le dita una banconota, e la guarda perplesso, e penso a quella volta che m’invitò allegramente sotto la tenda del suo equipaggio a mangiare coi marinai la zuppa di pesce con patate, cipolle e pomodori.
Se ora potessi dirgli quanto me la farebbero pagare una zuppa di pesce in una trattoria dei dintorni, certamente non ci crederebbe.